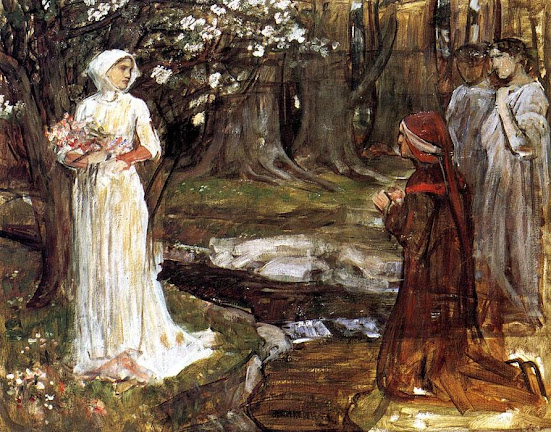I racconti ~ Il festival nella testa
 |
| Giorgio De Chirico, Il pensatore (1969) |
Coordinazione oculo-manuale pronta. Bagaglio umanistico di letterato precario laureato con lode pronto. Sentimento di frustrazione mista a sdegno da cui attingere copiosamente ogniqualvolta la ragione lo richieda pronto, prontissimo. Luogo in cui inscenare la tragedia, il dramma, la desolazione? Lo abbiamo. Via, partiamo, only the brave – gli anglicismi vanno di moda, viva le tre i – presto, non ce n’è di tempo in questo settembre selvaggio, nemmeno un giorno per scrivere un racconto, per studiarlo a dovere, per tararlo, calibrarne la mira: il racconto è come un proiettile scagliato dall’alto, citazione dai russi, il formalismo è superato, eppure... Only the brave, ma mi piace più il latino, fortuna audentes iuvat: ecco perché sei destinato a fallire, a naufragare in questo mare – dicevano fosse dolce – con l’imperizia di un nostalgico, morto come la lingua che rimpiangi e che ogni anno insegni rocambolescamente. Ci hai messo l’anima e ti sei fregato.
Ma via, avevo promesso una storia, un teatrino, eccolo: segreteria di liceo classico, segreteria di liceo scientifico, segreteria di liceo generico, segreteria di istituto tecnico, segreteria delle scuole medie e via a regredire, regrediamo verso i primordi. Segreteria scolastica, sei tu il mio richiamo della foresta, il mio settembre selvaggio!
“Buongiorno”, saluto precariamente, la testa piena di date e il curriculum in mano, ardente come la fiamma di Prometeo.
“Lo mettiamo insieme agli altri, nel mucchio.”
“La sensazioni quali sono, per quest’anno?”
Risata trattenuta a stento, ingoio l’amaro e penso al Maalox, un bel cucchiaio pieno, altro che nettare e ambrosia.
“Ancora è presto, ma se c’è qualcosa la chiameremo”.
Me ne vado da Monza, da Lecco, da sempre, le catene addosso e il fegato ventisettenne pluri-dilaniato dall’aquila olimpica, io solo con il mio segreto, come Montale nella sua aria di vetro andando un mattino. Me ne vado e ripenso alla mia laurea – serro i pugni, impreco, mentre ricevevo la lode avevo la certezza che avrei spaccato il mondo – ripenso al mio primo anno di insegnamento e a chi pianse durante il mio discorso di commiato.
“I hope you’ll come back someday”, disse Jill. Rimembri ancora quel tempo?
“Someday”, mentì Harmonica, altro stolto nostalgico, sopravvissuto alla vita ma morto, morto come la fiaba del suo West e quella del mio latino.
L’abbiamo fatto, il primo quadretto, un po’ pupazzata pirandelliana tragicomica un po’ Sergio Leone, eppure... quante altre cose ci sarebbero da dire, quanti altri luoghi e segreti! Quante citazioni nascoste, il più delle volte non colte, le altre quasi sempre travisate!
***
La seconda scenetta, a questo punto, è come se si delineasse da sé, quasi una sorta di emanazione spontanea: tre amici in macchina, gli stessi di una vita, altre strade, altre scelte, altre parole... Cosa ne sanno loro della selva di Teutoburgo, di Orlando morituro che soffia nel corno a Roncisvalle, del Beowulf tradotto da Tolkien, della sua amara consapevolezza che “la paga dell’eroismo è la morte?” Si parla di donne, della loro tredicesima e della mia disoccupazione, di locali: è così grande la Brianza, e la sua notte è così poco accademica! Il piede di uno di noi, il cavaliere di turno, preme sull’acceleratore: i cavalli scalpitano, i giri sbuffano, il cambio e lo sterzo diventano briglie, i pedali staffe; cos’è cambiato dal medioevo? Le nostre canzoni, al pari della migliore lirica trobadorica o cortese, passano sullo stereo e ci feriscono il cuore ricordandoci i nostri amori passati, gli anni che abbiamo perduto.
Così vaghiamo, microscopici eroi di un’epica proletaria, ombra di se stessa, di strada in strada, di giostra in giostra, ognuno ripensando ai casi suoi, loro inconsapevoli, quasi ebbri delle loro inimitabili imprese, più che certi dell’unicità del loro sentire, io no, troppa letteratura, ogni cosa è già stata vissuta, catalogata, detta con parole migliori: non c’è nulla di nuovo sotto il sole o sic transit gloria mundi, tanto è lo stesso, e io sono sempre stato più simile a un aedo o a un chierico, caro agli eroi, non eroe io stesso. Eppure eccomi, io e la mia allegra brigata, ce ne andiamo insieme sulle strade illuminate, sono nostre, altro che automobile di Marinetti nel manifesto futurista, io con i miei amori leopardiani, danteschi, petrarcheschi; loro, gli inconsapevoli, con un bagaglio necessariamente più catulliano e boccaccesco, ma in definitiva non meno infelice del mio – per questo ci capiamo, ci siamo sempre capiti – e io, che sono gracile e astemio, osservo tutto in silenzio: solo così i segreti diventano immortali.
Locale uno, locale due, locale tre; hamburger, pizza, giro-pizza, giro-carne, da Mc’Donald non mi vedete – lì non ci mangio, non ci lavoro, sono troppo letterato e soffro di gastrite – mani di poker texano, oboli spesi in gettoni del calcetto, parliamo di pallone, si grida, si ride, si impreca, mi preparo come un filologo per la schedina della domenica: sic transit gloria mundi, ancora: capisco Machiavelli relegato alla taverna. Oh, Lettera al Vettori, capolavoro insuperato, quanto ti penso in questo settembre straniante, quanto la tua malignità di fortuna mi ricorda il destino di mia vita! La noia e la rabbia, l’ambizione e l’ingegno: solitario mi mescolo alla marmaglia, respiro il fango dell’esilio – come il Milton di Fenoglio – e poi, finalmente solo, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio, mi cambio d’abito e mi pasco di quel cibo che solum è mio et che io nacqui per lui.
Che pasticciaccio di racconto sta venendo fuori, tipo stream of consciousness o neorealismo psicologico, e a me l’avanguardia non piace, Gadda non piace, Joyce non piace, troppo anti-narrativo, il modernismo è fin troppo moderno, finisce che mi violenta l’antico, l’armonia delle forme: che sofferenza scrivere così, ma in questo settembre selvaggio questo è l’unico racconto che potrei mai scrivere.
***
Terzo quadretto, Deo gratias l’ultimo. A spasso per le strade di Arcore o per quelle di Milano, non capisco bene, i due luoghi si sovrappongono, si confondono nella mia mente: l’Università che mi ha partorito con dolore mi guarda ora con distacco, quasi con sospetto. Il ritorno intrauterino mi è negato, la legittimità della successione pure: lasciate ogni speranza o voi ch’entrate.
Addio, Duomo di Milano, Mondadori, Palazzo Sormani – è così piccola per me Milano, è tutta fatta di libri –; addio, discorsi iper-letterari con l’amico che capisce! In questa nekuia conoscitiva ci siamo sprofondati insieme, se fossi Dante lui sarebbe Virgilio; s’i fossi foco... imprechiamo, non siamo affatto sicuri che usciremo a riveder le stelle.
Mi ritrovo improvvisamente nelle strade del mio quartiere, che ancora non ha capito cosa vuole fare da grande: il suo passato remoto di campi e cascine si intravede ancora, dandomi petrarchesco sollievo, eppure... le industrie e i capannoni del suo passato più prossimo sovrastano ogni cosa, dimostrano che tutto è cambiato. Nemmeno così mi dispiace, il grigio mi si addice, col verde fa contrasto, ne nasce una bella dialettica. Con la naturalezza di una buona abitudine scanso le vie più presenti, brulicanti di villette per i benestanti e di condomini per i nuovi servi della gleba, molti disoccupati e moltissimi immigrati: eccolo, il contemporaneo! Antichità agreste o malinconico grigiore; nido borghese o formicaio proletario; luogo di pianto o garage di Veicoli Utilitari Sportivi: parla, Cascina del Bruno, chi sei veramente? Porti il nome di un cavaliere, io lo so, me lo disse una volta un’amica in confidenza! Ma tutte le imprese avventurose dell’uomo che ti diede i natali si guardò bene dal dirmele, non sia mai che ci scrivessi una storia: aleggia dunque così, antico cavaliere, come un fantasma di altri tempi e ormai perduto, mentre mi aggiro errante lungo le tue strade e mi dirigo verso il centro, il cuore di Arcore città letteraria.
Varco la soglia del parco dei Borromeo, il centro del potere, inciampo come il Parini nella sua celebre ode. Lui abate, io precario; lui precettore di rampolli, Borromeo compresi, io precario, ancora; cammino inciampando sui suoi stessi sassi, sopra il medesimo senso di fine. Potrei farmi prete come lui, per seguire la mia vocazione? Rido per non piangere. Claudicava, il Parini, si aiutava col bastone, eppure... Il Parini, o della gloria, tale l’operetta del contino Leopardi, le anime migliori se le prende tutte il dolore.
Sono alti, gli alberi del parco: il mio amico giardiniere, uno dei prodi, una o due volte all’anno su mia insistente richiesta mi indica i loro nomi, un puro esercizio di stile, saranno presto restituiti all’oblio... Mi inoltro nel verde e arrivo alla Villa: trattengo una smorfia constatando che il palazzo dei Borromeo, da sempre nella mia memoria fatiscente e spettrale, è adesso in pieno restauro. Mirabilmente l’amministrazione comunale tenta di defibrillarlo, di riportare la Gran Dama alla vita: lo slancio è idealistico, fa onore alla città; io però già rimpiango i fantasmi, sospiro le anacronistiche rovine, il latino e il medioevo, paradisi perduti. Supero quasi in corsa la Cappella Vela, sempre nel parco, le sue meraviglie: non ho cuore di ammirarle ora. Oltrepasso le Scuderie, ripenso alla presentazione del mio primo romanzo, carne per gli avvoltoi nel deserto...
Chi ci sarà per la nuova edizione del festival, quali trionfi saranno celebrati? Simile a uno spettro invendicato mi aggiro invisibile, sconosciuto ai più, sul luogo del crimine efferato, dello scempio: il festival della letteratura io ce l’ho nella testa. Ariosto presenterà il suo poema, terrà un discorso irresistibile sulla vanitas e il tema della quête; Pascoli e Dante, Omero presente, spiegheranno insieme la fine di Ulisse; Tolkien racconterà tra una pipata e l’altra del suo vizio segreto di creare nuovi linguaggi, popoli e miti. Ho invitato tutti i miei autori, credetemi, per questo meraviglioso teatrino: Leopardi e Machiavelli per la misantropia, Tasso e Virgilio per la metrica; Petrarca sta preparando qualcosa in grande stile, come al suo solito: cosa non farebbe per farla in barba a Dante! Sia Pietro Bembo sia Boccaccio mi hanno assicurato che presenzieranno e che sarà la fine del mondo (eppure, mentre lo diceva, l’autore del Decameron rideva...).
È strano, ma nessuno sembra curarsi del fatto che si stia solo tra morti; gli spettri mi incalzano e, non senza entusiasmo, mi domandano una data: rispondo che il nostro festival è tutti i giorni e dura tutto l’anno, ma Italo Calvino non è d’accordo, mi rimprovera di essere troppo approssimativo, mi esorta a scegliere un mese per il gran finale, ma forse è l’inaugurazione, non ne sono sicuro: in un primo istante, trascinato dall’enfasi del momento, sto per proferire settembre, il mio mese, mai tanto selvaggio e malinconico come quest’anno, poi però mi correggo e razionalmente asserisco che il momento giusto è a novembre, quando tutto muore: sia dunque quella, la nostra festa, la nostra tragedia; e mentre già mi preparo ad inscenarla tra me e me non riesco a fare a meno di sorridere, camminando o sedendo pensoso ai giardinetti pubblici, tra le macerie delle mie stesse parole.
_______________
Copyright © 2020
Tutti i diritti riservati.